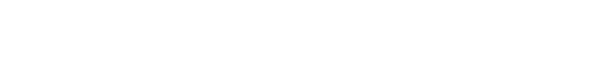La luce di Piero [1992] letto da Monica Mazzolani e Antonio Troisi
L’Ateneo ricorda Carlo Bo nell’anno ventennale della sua scomparsa.
Anche se mi sembra del tutto superflua sento il dovere di fare subito una precisazione, non farò una relazione, il mio sarà soltanto un omaggio a Piero della Francesca che gli urbinati considerano uno dei loro grandi figli.
Non potrei fare altro, per parlare di Piero non ho né gli strumenti né i mezzi, sia pure quelli ridotti e limitati dei letterati che accidentalmente si occupano di un pittore.
Caso mai, a volere forzare le cose potrei dire che l’unico titolo è quello di aver passato gran parte della mia vita sotto questo cielo che anche lui ha visto e restituito, in questa luce, fra queste colline che il tempo non ha potuto per ora modificare.
Ma questo rientra nel capitale perenne dell’arte confrontata alla natura: un pittore guarda, fa sua la natura e poi ci restituisce qualcosa che non è più soggetta a modificazioni e a correzioni.
Credo che ogni urbinate che si sia interrogato sulla grazia della sua terra abbia sempre fatto riferimento a questo artista che per tre anni ha lavorato nella nostra città: un riferimento che fa ameno di confronti, è una cosa che c’è e rimarrà fino a quando il tempo non cancellerà le ultime tracce di questo tipo di naturale convivenza.
Direi che è uno dei casi di quella costanza fra opera e paese di cui parla un poeta francese dei nostri tempi, Bonnefoy, che ha sempre saputo guardare Piero con gli occhi dell’intelligenza amorosa.
Ma quando si passa ad analizzare meglio tale rapporto ci si accorge che tanta luce contiene una parte di mistero fino a presumere una delle tante ipotesi che si sono fatte e si faranno sull’arte di Piero e cioè che al di là della scienza invocata e stabilita c’è qualcosa che investe e dissolve la cura, lo scrupolo e la pazienza della rappresentazione.
La conferma ci viene dai due maggiori dati del suo genio, la luce e il paesaggio che non sono più soltanto delle nuove soluzioni ma sono l’indice di una seconda visione che presiede alla creazione dei suoi grandi quadri.
Mi sembra che non si possano considerare soltanto come delle scoperte, come una delle rare deviazioni rispetto alla storia e alla tradizione, ma come delle spie di una diversa coscienza dell’arte, meglio come una confessione e un’invocazione.
Per quello che ci racconta è stato fatto un grande lavoro critico, a partire dal capolavoro di Roberto Longhi, maestro di critica ma anche di scrittura, sicché sappiamo molte cose delle ragioni storiche, delle illusioni, insomma di quello che l’artista ha calato dentro le sue rappresentazioni epperò tutto serve, tutto ci soddisfa ma non annulla il significato di quella luce, il senso di quei paesaggi che non sono appena degli omaggi alla propria storia personale una sorta di seconda firma apposta sull’opera finita.
Direi che ci siano in queste due costanti il dato del mistero, tutta una serie di domande che devono pure avere tormentato l’artista anche nei momenti di maggiore soddisfazione e di pace interiore.
Sono due elementi – se si guarda bene – che non consentono insinuazioni di nessun genere e alla fine stanno al di fuori di ogni possibile ricognizione storica e sono infatti i segni immutabili dell’eterno, le punte vive del nostro destino di uomini.
Da questo punto di vista non ci sembra più consentito parlare di sistemazione o di collocazione ma al contrario ci sembra doveroso parlare di un contrasto o di contrapposizione: da una parte la storia divina e umana e dall’altra uno scenario che non sopporta distinzioni, separazioni, essendo un unicum che, come dicevamo, appartiene al dominio del mistero.
Né sembri una contraddizione tale rapporto fra la luce e il buio del mistero, fra l’anonimato della terra e la gloria della storia.
È quel mistero della luce piena di cui parlava uno scrittore del passato, il Barrès, e che coincide con il sentimento della nostra impotenza o della nostra limitatezza.
La gran luce di Piero invece non ha limiti e i suoi paesaggi sono dotati di una straordinaria forza di propulsione e di ripetizione all’infinito: due cose che separano nettamente il regno del conoscibile, del visibile e il regno dell’invisibile e del simbolico.
Ecco che allora le rappresentazioni sacre e umane appaiono come degli escamotages, degli accorgimenti solenni per impedire la vittoria della morte, i soprusi del mistero.
Le rappresentazioni sono per questo fedeli ai testi sacri dell’umanità, potremmo dire scrupolosi dal momento che implicano molte conoscenze e recuperano motivi e elementi propri della grande storia.
Se non avessimo paura di abusare, di esagerare, vorremmo dire che Piero ha confessato indirettamente questi sospetti fornendoci la prova della bontà delle nostre supposizioni con il suo proposito di fare dell’arte della scienza, di chiudere dentro limiti ben precisi la forza e l’intensità del visibile.
Del resto ciò che ci sembra di cogliere nella sua impresa è stato sempre più confermato tutte le volte che ci si soffermi a misurare la gloria e la miseria dell’arte.
Nel nostro caso, c’è un particolare della Resurrezione che ci ha sempre colpito nei moti di questi ragionamenti: penso al soldato ai piedi della tomba del Cristo risorto che si tappa gli occhi, non si sa per il terrore della visione o per rientrare nel sonno.
È un po’ l’altra parte della figura in cui si ravvisa lo stesso artista, il suo volto stanco, il gozzo: Piero dorme pesantemente, il soldato è posto – lui per primo – di fronte al mistero e alla domanda angosciata: è il Cristo risorto, è la sconfitta della morte o, meglio ancora, il terrore di guardare oltre, al di là della realtà?
È certo un atteggiamento passeggero che poi, subito dopo il disvelamento della Resurrezione, dell’ultimo miracolo sarà condannato a scomparire, ma tuttavia è un indizio di quella che senza dubbio Piero come del resto tutti gli uomini sentono, il difficile passaggio tra la realtà e il mistero, fra le cose visibili e la parte dell’invisibile che le avvolge.
Che poi è ciò che il pittore fa tutte le volte che sistema le sue storie dentro il mondo, che conosciamo soltanto dall’esterno o le bagna nella luce che è sempre di un’altra natura e sconfigge il nero della storia.
Non si insisterà mai abbastanza sul potere e la virtù di questa luce, sulla forza di ammorbidimento dei suoi paesaggi, insomma sulla forza del mistero che compone le cose e ricompatta le azioni degli uomini non le assolve ma le spiega.
Cosa che non sanno fare i protagonisti della Flagellazione, vittime di altri misteri e per questo imperscrutabili.
La grande luce inventata da Piero è una medicina per i nostri mali, cura le asperità, le violenze, quel dato eterno che avvelena le ragioni della nostra storia.
Mi si dirà che proprio per questo aveva letto secondo lo spirito di nobiltà e di grandezza le nostre vicende e aveva sin dalla nascita o addirittura dal parto esaltato la nostra dignità ma le sue storie si tengono fra la vita e la morte, nonostante tutto partecipano della festa del sangue mentre la luce, i paesaggi sono fatti di materia celeste, sono – come si sarebbe detto molti secoli dopo – poesia pura.
Non è dunque un caso che l’artista sia tornato in forze nel nostro secolo che della poesia pura è stato testimone e molti pittori italiani del Novecento lo abbiano inserito nel libro dei maestri.
Questa mi sembra la lezione stupenda che ha dato, dà e darà Piero anche agli ignari, anche ai poveri passeggeri come me che lo hanno sempre guardato nel chiuso del Palazzo e soprattutto dentro le vene poetiche del paese: una lezione che trova ogni giorno conferma.
Le mie umili, semplici e modeste parole vadano ad aggiungersi allo sterminato lavoro dei dotti e degli scrutatori, non hanno nessuna pretesa, solo quella di rendere grazie a un inventore che ha fatto della bellezza una ragione giustificata e spiegata.
Voci: Monica Mazzolani e Antonio Troisi – Fotografia: Bob Krieger