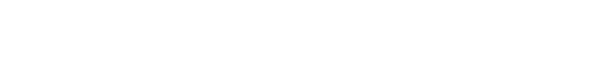Cittadino di Urbino [1959] Letto da Giorgio Calcagnini
L’Ateneo ricorda Carlo Bo nell’anno ventennale della sua scomparsa.
[…] Nell’ottobre scorso si sono compiuti vent’anni da quando sono venuto per la prima volta in Urbino, accompagnato dal mio Preside, professor Rebora. Venivo per iniziare il mio insegnamento come incaricato di letteratura francese della nuova Facoltà di Magistero: sono passati vent’anni, sono ancora qui, non ho fatto la solita carriera universitaria legata a tappe ben precise, ma penso di aver guadagnato molto in questo cambio di rotta o, soltanto, in questo rallentamento di tempi. Quello che ho imparato a Urbino sul piano umano vale molto di più per una buona intelligenza della vita: è di per sé un premio.
Quando sono arrivato, in quella lontana domenica d’ottobre del 1938, portavo con me soltanto il piccolo bagaglio della mia cultura, ero soprattutto un letterato di avanguardia che aveva costruito – un po’ per ragioni di natura, un po’ perché spinto dalle ragioni del tempo che allora non erano fatte per consolare – tutto il suo edificio al di fuori della realtà.
La cultura era un’operazione chiusa da svolgersi lontano dal contatto con gli altri uomini. Fu allora che cominciai a godere qualcosa, a guadagnare dall’Università: quella cultura si era rivelata inutile, bisognava adattarla alla misura degli studenti, a chi chiedeva una forma di dialogo più umile e più concreto. Non fu facile ritagliarmi sulla vecchia sagoma ambiziosa e segreta un’immagine più aderente, più viva ma alla fine riuscii a trovare che cosa era necessario per parlare, per farsi capire, insomma per stabilire quel contatto senza di cui la scuola muore.
Infine quando i colleghi nel 1947 mi elessero Rettore ebbi modo di allargare ancora di più il campo della visione pratica. Fino a quel momento, pur avendo fatto uno sforzo per accostarmi agli studenti, le cose erano rimaste sul piano puramente culturale: ignoravo quello che è il fondo primo della vita, intravvedendo soltanto, e dal di fuori, l’enorme massa di problemi diretti che angosciava l’esistenza dei nostri studenti. Da allora ho dovuto fare una grande pratica di vicende, di dolori, di pene: lo studente che batte alle porte del Rettore, quando riesca a superare lo stato di timidezza e di riserbo, è molto diverso dallo studente che vediamo a lezione o agli esami. Egli porta con sé tutto il capitale di memorie, porta il segno delle sue tradizioni, della sua educazione, della sua famiglia: insomma porta il volto vero che per forza di cose viene trascurato o lasciato in ombra nelle relazioni ufficiali. In questo modo cominciai ad avere l’esatta proporzione delle cose: l’Università non poteva essere soltanto un luogo d’incontro, una sede, un centro culturale ma qualcosa di più vasto e intimo insieme. Da quel momento ho sempre considerato la nostra Università come una famiglia, come qualcosa di vivo e che non dovesse essere limitato al giuoco accademico.
[…] Il Professore Canzio Ricci, nei venti anni del suo inimitabile rettorato, ha insegnato a tutti come si possa essere veri nell’umiltà e più ricchi nella consuetudine dell’amicizia. È dunque a lui che devo per primo rendere l’onore che mi fate oggi, a Lui e a tutti i colleghi che ho conosciuto e imparato a stimare in così lungo spazio di tempo e che mi hanno aiutato, sostenuto e incoraggiato. […]
Sono, dunque, queste preziose qualità umane a fare dell’Università una sede unica per chi intende cercare nella scuola qualcosa di più profondamente legato alla radice della vita. Ora io non ho ancora finito di imparare, di correggere il mio naturale distacco dalle cose, dalla realtà e questo dono che mi è stato fatto, che mi si fa ancora di umanità vale molto di più di quello che, bene o male, ho fatto e della piccola parte di dottrina che sono in grado di mettere a disposizione dei miei studenti. Perché se mi chiedo “che cosa ho fatto?”, misuro soltanto velleità, omissioni, insomma quasi nulla. Quando devo tirare le somme di vent’anni di insegnamento e di dodici anni di rettorato, non posso che restare sgomento di fronte al mio debito. Ma passato questo tempo di incertezza e di stupore, faccio una promessa che non vale soltanto per me ma per tutti i miei Colleghi e per i funzionari dell’Università. Voglio che sia una promessa solenne, sinceramente dichiarata davanti a Lei, signor Sindaco, e alla Giunta e al Consiglio Comunale, davanti alle Autorità che hanno voluto rendere più solenne la cerimonia e infine di fronte alla cittadinanza, a questo popolo gentile di Urbino: prometto che faremo tutto il possibile non solo per difendere l’Università ma anche per potenziarla, per renderla sempre più agile, viva, attuale.
C’è un patrimonio incalcolabile che traspare dagli ori delle memorie e della tradizione, c’è un fondo di rispetto e di amore per l’uomo che proprio in questo stupendo palazzo ha avuto, molti secoli fa, la sua straordinaria consacrazione, ebbene noi aspiriamo – se non è un’ambizione troppo alta – a mantenere viva quella luce, a fare in modo che l’Università rappresenti per Urbino non una scuola come ce ne sono tante, ma una scuola particolare, dove la libertà, i diritti dell’uomo siano costantemente rispettati e nell’insegnamento e nei rapporti con i nostri studenti. È un duro lavoro di inserimento: lasciatelo dire da chi viene da un paese forse altrettanto bello ma non toccato dalla storia, dal lavoro più alto degli uomini, lasciatevelo dire: la memoria di Urbino è troppo forte, a volte appare schiacciante, quasi certamente quello che è stato fatto qui, quella coincidenza unica di miracoli del Rinascimento non si verificherà più, ebbene non importa, noi abbiamo il dovere di imitare quel modello di vita, imitarlo da uomini di oggi e nel segno dell’amore, della pietà e della carità degli uomini, in un mondo che sembra aver dimenticato questi limiti indispensabili.
E dico “noi”, dico “dobbiamo” perché oggi non parlo soltanto come un professore o il Rettore dell’Università ma come un cittadino di Urbino, con la speranza che un onore si traduca immediatamente in una forma di attiva collaborazione. Ed è come cittadino che voglio qui ringraziare il Sindaco e tutti gli altri cittadini di Urbino che tengono alta nel cuore l’Università e hanno imparato a sentirla viva, aperta, gelosa della sua antichissima libertà.
[Pronunciato nella Sala del Trono di Palazzo Ducale nell’occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Urbino il 26 aprile 1959, e quindi pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Urbino nel volume: Una cerimonia democratica. Per il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Bo, Rettore Magnifico dell’Università, questo testo emblematico del rapporto identitario che Carlo Bo ebbe con l’Istituzione che rappresentava, e con la città ducale, entrò poi a far parte del volume: Carlo Bo, Discorsi rettorali, Argalia, Urbino 1973, e quindi del volume: Parole sulla città dell’anima, a c. di G. Santini, Comune di Urbino 1997, e del volume: Città dell’anima. Scritti sulle Marche e i marchigiani, a c. di U. Vogt, Ancona, Il Lavoro Editoriale 2000. Qui è interpretato da Giorgio Calcagnini, duplicemente cittadino di Urbino, per nascita e mandato rettorale.]
Voce: Giorgio Calcagnini – Fotografia: Bob Krieger